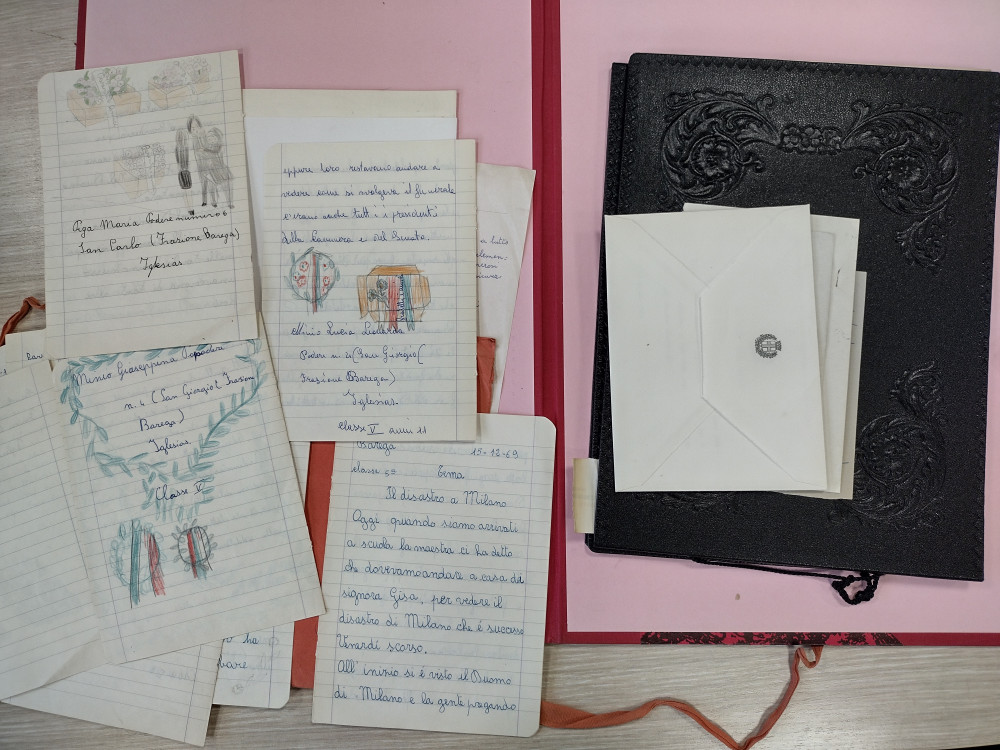Le Voci della Memoria
Per la sua realizzazione sono state raccolte le testimonianze di dieci persone, alcune delle quali giovani studenti di allora, che hanno vissuto da vicino gli eventi successivi all’attentato. Il fine era quello di rendere un tributo di riconoscenza alle donne ed agli uomini che, partecipando ai funerali del 15 dicembre 1969, non sono rimasti indifferenti di fronte ai pericoli e alle minacce che incombevano sulla democrazia nel nostro Paese.
Un Lavoro Corale tra Storia e Comunicazione
Fondazione ISEC ha coinvolto giovani studenti e volontari del Servizio Civile Universale per raccogliere, registrare e montare il materiale documentario. Il risultato è un video di circa 40 minuti, liberamente fruibile sul sito della Fondazione e pensato per l’uso didattico.
In particolare, il giovane studente universitario ha curato direttamente le interviste, permettendo ai testimoni di seguire il filo logico dei propri pensieri e anche di divagare sugli argomenti ritenuti più importanti, in modo da catturare i ricordi nella loro forma più grezza e inalterata. Al volontario del Servizio Civile Universale è stato richiesto di mettere a disposizione le proprie competenze nel campo della comunicazione e della produzione multimediale, curando il montaggio e l’assemblaggio del materiale in un prodotto unitario e scorrevole.
Storia e Didattica: Un Legame Complesso
La trasmissione della memoria storica nelle scuole non è priva di sfide. Se da un lato le testimonianze dirette affascinano gli studenti, dall’altro emergono difficoltà nel connettere il passato con il loro presente. Come far sì che questi eventi non appaiano solo come episodi lontani e privi di rilevanza?
Nonostante l’indiscutibile impatto che i testimoni di eventi storici più o meno traumatici hanno sulla classe, la loro presenza e il loro modo di connettersi alle attività curricolari non è esente da elementi di problematicità. In linea generale, vi possono essere, infatti, testimoni che, accanto ai propri ricordi, collocano le narrazioni più diverse: da considerazioni più o meno argomentate sull’attualità a inquadramenti storici non sempre supportati da adeguate letture, da generalizzazioni talvolta azzardate a concioni che non di rado colpevolizzano la gioventù e le sue asprezze o, al contrario, altri che tendono a cercare una complicità che, lontana dal portare l’adolescente verso l’età adulta, rischia di portare l’adulto verso un’età che ormai da tempo non è più la sua.
Consapevoli di questi rischi si è provato comunque a mettere a disposizione delle classi una memoria degli eventi del 12 dicembre ’69 e della risposta di Milano e dell’Italia intera nei giorni successivi.
La Voce degli Insegnanti: Un’Esperienza sul Campo
Alcuni docenti hanno condiviso le reazioni dei loro studenti alla visione del documentario. Molti si sono immedesimati nei giovani del ’69, altri hanno percepito la strage come un evento distante. La scuola ha il compito di colmare questa distanza, bilanciando emozione e razionalità nella trasmissione della memoria.
Due risposte hanno attirato in particolare la nostra attenzione.
Ci scrive una docente: «ho proposto ai miei studenti di quinta il video di circa 40 minuti sulla strage di piazza Fontana e quasi tutti erano molto interessati, soprattutto quando i testimoni erano studenti come loro di 18 anni a quel tempo».
Un’altra docente ci dice: «ho riservato un’ora di educazione civica alla visione di parte del docu-film e del materiale su Piazza Fontana. Ho due quinte, una che […] ha visto il video ma ha rielaborato poco i contenuti; un’altra più curiosa e attenta. In ogni caso per tutte e due le classi le immagini sembrano appartenere a un tempo lontanissimo. La cosa su cui ci siamo soffermati di più è il concetto di “perdita dell’innocenza” e di fine di un’epoca. Riprenderò l’argomento verso fine anno».
Riflessioni preziose che suscitano almeno un paio di considerazioni.
La prima riguarda un dato che probabilmente i/le docenti conoscono e cioè il frequente riemergere di questa sorta di connessione quasi direttamente generazionale tra i ragazzi di oggi e quelli di ieri. Non si tratta, infatti, di un rapporto inter-generazionale, ma, con tutte le ineludibili differenze tra l’oggi e 55 anni fa, di un rapporto quasi direttamente generazionale tra chi ha su per giù diciott’anni oggi e chi aveva la stessa età nel 1969.
La seconda riguarda, invece, la lontananza. Alla docente risulta ovvio un dato che, invece, fuori dalla scuola si fa molta fatica ad accettare: fatti importantissimi, sia sotto il profilo storico sia per le conseguenze determinate in chi ne ha fatto diretta esperienza, non entrano nell’orizzonte di senso dei giovani.
«Riprenderò l’argomento verso fine anno» esprime, ci sembra, un atteggiamento esemplare che contiene diversi elementi: una laica consapevolezza di questa lontananza; la presa in carico da parte della scuola della responsabilità di avvicinare quei fatti e renderli significativi; l’ulteriore consapevolezza che il terreno su cui questo delicato processo si gioca è sospeso tra l’emotività e la cognizione e che un/una docente sa di dover dosare, l’una e l’altra, secondo la classe che ha davanti.
Memoria in Cammino
Il progetto non si conclude qui: nuove tappe e incontri sono in programma. Il coinvolgimento degli insegnanti sarà essenziale per guidare gli studenti nella comprensione del passato, trasformando la memoria storica in una bussola per il futuro.
LINK UTILI